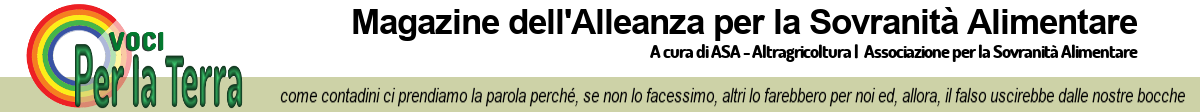fonte: la Nuova Sardegna (vedi articolo originale)
Se un po’ tutti i mestieri tradizionali possiedono un’anima che ne connota l’intima essenza ben al di là del loro “valore d’uso”, il mestiere del vignaiolo – su inzatteri – si colloca su un crinale ancora diverso, intriso di una mistica e di un rituale che sanno di esoterismo (le dottrine di carattere segreto i cui insegnamenti sono riservati agli iniziati). Sarà per il miracolo millenario della vinificazione, sarà per le passioni e le pulsioni che quel liquido gradevole al palato è in grado di muovere, sarà per la sua spiccata vocazione socializzante, fatto sta che il vino assurge ad “una vera e propria liturgia pagana, scandita com’è da una serie di tappe dal valore fortemente simbolico e impregnata di religiosità” (Andrea Cannas che parla del “Giorno del giudizio” di Salvatore Satta). Di quei significati è consapevole zio Pietrino Gaspa, 80 anni, uno degli ultimi vignaioli di Osilo. «Intorno al vino e alla vinificazione – ricorda – c’erano molte superstizioni e leggende, ma anche buone pratiche dettate dall’esperienza». Quell’esperienza che Pietrinoapplicava alla sua vigna di “Coros”, sulla strada per Tergu, 4500 ceppi per una resa di 25/30 ettolitri l’anno. «Producevamo un vino raro per Osilo – ricorda l’uomo – che poteva raggiungere i 14/15 gradi (mentre nel resto del territorio osilese si viaggiava intorno ai 10 gradi), e che non aveva niente da invidiare ai più blasonati vini della vicina Sorso».
Il segreto stava nella terra calcarea bianca della zona, posta a 142 metri sul livello del mare, e nella sua esposizione al sole per l’intera giornata e al riparo dai venti dominanti. Una vigna interamente impiantata da Pietrino Gaspa e dai fratelli, partendo dalla realizzazione del vivaio di vite americana, dalla messa a dimora delle barbatelle e dal loro innesto con i tralci di uve buone, a spacco inglese o “a isperru”. Dopo l’impianto, la vigna veniva seguita dal vignaiolo con l’amore che si porta ad un neonato. Per tre anni andavano eliminate le radichette degli innesti, mentre nelle diverse fasi bisognava contrastare le malattie che potevano attaccare la vite – la peronospora in particolare. E qua, Pietrino Gaspa ricorda con simpatia la “tecnologia” che si utilizzava quando non esistevano ancora le macchine per “meigare”. «Lo zolfo si dava su ciascun grappolo con una calza di nylon, scuotendola leggermente». La vendemmia avveniva dopo il 10 ottobre, “a piccole dosi”. «Si tagliava tanta uva quanta ce ne stava in su laccu perché la pigiatura si faceva con i piedi, e non si poteva esagerare con la quantità».
Al secondo giorno si poteva già passare alla torchiatura, e dopo un altro giorno – ma si parla di un vino già forte di suo – veniva travasato nelle botti per la fermentazione. «Stando attenti – precisa Pietrino Gaspa – che nella cantina non ci fosse niente (carbone, formaggio, odori forti), perché il vino assorbe tutti gli aromi. Il nostro vino – conclude il vignaiolo – non si poteva bere prima di gennaio-febbraio. Ma da allora in poi, non c’erano spuntini, “tusolzos” (tosature), “cumpridolza ‘e messare” (la fine della mietitura), che non venissero onorate da abbondanti bevute. La gente lavorava da matti – aggiunge l’uomo – ma, a differenza di oggi, era contenta. Succedeva che magari cantassero “a poesia” e bevessero fino alla mezzanotte, ma poi, alle cinque del mattino, erano di nuovo pronti per iniziare una nuova giornata di fatica». Grazie anche a quella che in fondo è una delle migliori qualità del vino: dolce compagno di vita e di socialità.
Mario Bonu