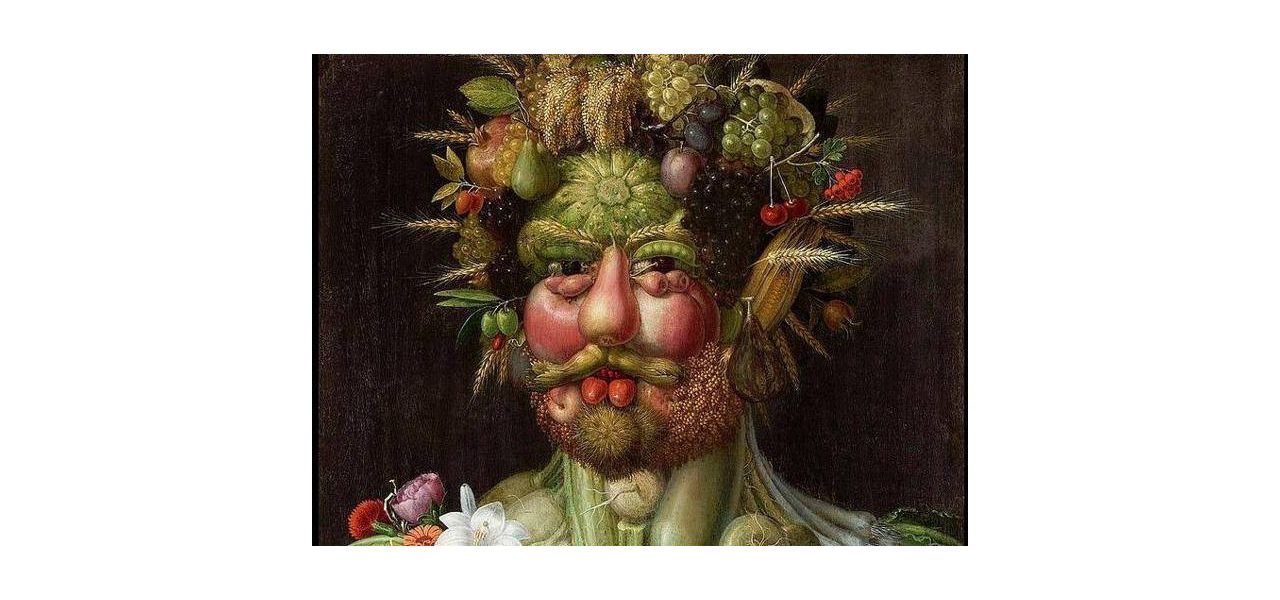editoriale del 29.04.2021 di Guido Cortese
Dietro Chivasso, alle porte di Torino, alcuni anziani coltivano e custodiscono una varietà di insalata chiamata ‘di Castagneto Po’- Interessante per resistere sotto la neve e sfamare tutto l’inverno, è una rosetta persino gustosa ed è stato possibile conoscerla grazie a un progetto di ALCOTRA che l’ha riselezionata e riprodotta per restituirla alla comunità locale. In un filmato realizzato per testimoniare questo processo di difesa del seme, un anziano racconta che un secolo fa questa insalata era così importante che fungeva da ‘moneta’ di scambio per pagare i muratori. Vi immaginereste, voi, con quanta insalata nella plastica potreste pagare oggi un impresa edile?
Spesse volte ci è capitato di dire o sentirci dire che ‘siamo quello che mangiamo’.
Non ci sono mai stato dentro questa formula ma ci sono voluti decenni per disegnarmi un quadro che potesse darmi piena soddisfazione cioè rispondere al perchè io dico che NON siamo quello che mangiamo.
La ragione anzi le ragioni giacevano nella mia testa ma non sapevo ascoltarle.
Pochi giorni fa ho seguito un intervento di Mancuso nella lectio magistralis ‘dal seme alla tavola’ per Terra Madre 2020 a cui è seguita una Tavola rotonda con Fausto Jori di NaturaSì, Federica Bigongiali di Fondazione Seminare il Futuro e Carlo Petrini Presidente di Slow Food, con le conclusioni di Maurizio Martina, Vice Direttore Generale Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) e meravigliosamente moderato dalla giornalista Sabrina Giannini, che conosciamo bene per Indovina chi viene a Cena su Rai3.
(CIT https://www.facebook.com/naturasi.italia/videos/203565814593904)
In questo incontro sono state dette migliaia di cose, una che mi ha colpito è la quantità di specie vegetali che l’uomo primitivo mangiava abitualmente: più di 200! Da qui un salto all’era moderna, evidenziando il numero di specie di cui ci si nutriva in Francia ai tempi della rivoluzione francese: circa 50. Quantità da cui vanno escluse le specie ‘esotiche’ come il pomodoro, che ci sembra tanto scontato (e ibridato) ma all’epoca inaccessibile al popolo. E si conclude con il nostro tempo, con un numero di specie di vegetali di cui si nutre un italiano medio: solo 16.
Se a questo seguono i nessi causali tra lo stato di conservazione della biodiversità del pianeta, sfruttamento dei suoli e dei mari e pandemia più volte ribaditi durante il dibattito, si scorgono i tratti di un pensiero laterale che cerca di unire le tante conclusioni apparentemente slegate in una soltanto. Il successo del nostro futuro, della nostra salute e di quella del pianeta dipenderanno dal modello di agricoltura che vogliamo costruire insieme.
E non significa passare per radicali. Tutt’altro ‘estremo’ o estremista è quanto è accaduto finora se pensiamo ai tanti esperimenti e ricerche che hanno permesso al contadino moderno di emanciparsi per dominare la terra, poiché brevettare un pesticida o diserbante e altrettanto un seme modificato da abbinare al pesticida sono l’espressione di questa estremità, tanto nefasta daspingere l’Unione Europea ad aprirsi verso una ‘strategia biodiversità’ o L’Italia a osare con timidezza l’istituzione di un dicastero per la transizione ecologica.
Dietro l’omologazione della produzione agricola c’è allora la standardizzazione dei sapori e poi delle pratiche alimentari domestiche. Per pigrizia, per poco tempo a disposizione dovuto a sua volta dalla compressione degli spazi e dei tempi familiari o di condizioni lavorative sempre meno tutelate, il fast food negli ultimi 20 anni non è più soltanto un ‘piacere’ da consumare fuori casa ma è ‘dentro le mura domestiche’.
Non è un caso se già nel 2003 la più importante rete di distribuzione del latte torinese palesava come terza linea di vendita (per fatturato) l’insalata lavata e insacchettata, disponibile nella grande distribuzione.
Il paradosso, è appunto questo. Disporre di tecnologie, energia, conoscenza così elevate rispetto al nostro antenato, ma costringere il consumatore ad assuefarsi ad una nutrizione insufficiente ma sapida, frutto di una terra incapace di essere autofertile perchè perennemente annientata dai pesticidi e con paesaggi sempre meno variegati, in cui la vita e le stratificazioni delle specie vegetali si è ridotta a una o due o tre soltanto per ettaro.
Il segreto della salute del pianeta, si sente, è nascosto nelle dinamiche di vita tra tutte le specie viventi, per come si sono evolute in migliaia di anni, in cui ogni parte gioca un ruolo fondamentale con dinamiche e capacità di comunicare che stiamo appena iniziando a scoprire. Tanto da interrogarci sul fatto che interrompendo l’uso di tanti fitofarmaci non si possa ristabilire questa connessione così vitale non solo per l’ambiente ma anche per la nostra salute.
Daltronde molte metropoli del pianeta hanno visto rifiorire il tema della produzione urbana, che sta assumendo un peso significativo e non mi riferisco solo all’autoconsumo. Sono esempi interessanti perchè al di là dei numeri emerge il desiderio di esprimere liberamente l’esercizio e l’indirizzo della pratica agricola. Nata come risposta alle crisi, oggi la produzione urbana è un avamposto della vera emancipazione agricola. L’apicoltura urbana ne è un esempio. Non lo dico perchè parlo da apicoltore e apicoltore urbano, anzi ritengo che la città non debba essere un modello di autoproduzione individuale. Non credo sia sostenibile e non è immaginabile una città di un milione di abitanti con altrettanti milioni di balconi con i vasi di pomodoro.
Tuttavia la riflessione ci serve a ribaltare il problema, rispetto ai tanti ‘mali’ che vengono additati come nemici della nostra sopravvivenza, spesso usati per giustificare politiche agricole sempre più aggressive. Il clima è cambiato? bisogna comprare tecnologia predittiva. Specie parassite aliene? Insetticidi e trattamenti. L’importante è massimizzare la resa perchè la domanda di cibo (e di carne che prima mangia cibo) è in aumento.
La libertà di coltivare invece permette a nuovi ‘sperimentatori’ di scoprire che esistono alternative certe e una produzione sana e sicura di cibo.
Purtroppo è difficile produrre cibo sano semplicemente scegliendo un seme e piantandolo dietro casa. Tutto il contesto deve tornare integro. Non possiamo pretendere un esistenza sana e pienamente libera, tornando al nostro antenato povero ma fortunato (e ampio conoscitore di verdure) senza un contesto integro.
L’integrità di un suolo o di un mare, come ogni sistema, è garantita dalla presenza equilibrata di batteri, funghi, insetti, animali e vegetali e dalla diversità delle specie e certamente disintossicato da veleni. Eliminare un elemento di questa catena significa indebolire il sistema.
Parlare di sovranità alimentare senza pensare di ricreare le condizioni di equilibrio per un ambiente, suolo e mare salubri è inutile.
Per questo, per quanto possa suonare acerba la transizione ecologica, è necessario credere e pretendere un cibo sano per tutti.
Questo passaggio, cruciale, implica due strade.
Quella dell’utopia dell’iper tecnologia, quale surroga per un impollinazione meccanica e manuale di un pianeta sterile. E quella della sovranità agricola, che ribadisce una spontanea e gratuita produttività terrestre. Se vi dicessero che per godere della vostra ‘sovranità’ alimentare basta rispettare la terra e riequilibrarla o che si debbano pagare semi brevettati e poi relativi farmaci e pesticidi in abbinata, ma poi costi veterinari per lo stress e le malattie precoci al bestiame e ancora costi di consulenza, impegnarvi a vivere di sussidiarietà protocollando bandi di sostegno senza contare gli effetti derivanti dalla sovraesposizione ai trattamenti che sottoporreste alle coltivazioni per cui visite mediche specialistiche, terapie farmacologiche, ospedali.. etc. .cosa scegliereste?
Se dietro ogni pomodoro, per quanto sofisticato e attraente, c’è una o due varietà di seme brevettato, e se vacche e maiali mangiano tonnellate di mais e soia fatti con quei brevetti, e se le farine a loro volta sono ottenute con varietà comode e copiose allora quella carne, quelle verdure, quella pizza non sono tanto diverse da miliardi di viti o dadi di metallo della stessa forma e peso e colore, che escono da una fabbrica!.
Verso l’omologazione della produzione seriale c’è una altrettanta stratificazione di pochi elementi, che compongono la nostra materia e la nostra speranza.
Se il cibo quotidiano dipende dal mercato e dalla produzione massiva di pochi ‘big’ dell’agricoltura mondiale (che godono dei massimi benefici dei piani di sviluppo rurali) e se questo cibo è ottenuto con poche varietà che nutrono il pianeta allora noi non siamo più quello che mangiamo.
Noi siamo quello che mangiano gli altri. E’ questo un altro paradosso, se pensiamo al fatto di essere ormai cloni di pochi elementi chimici di questa agricoltura moderna a cui va aggiunto il peso dei 15 chilogrammi pro-capite di fertilizzanti che assume ogni anno un cittadino italiano tramite il cibo che mangia.
Dietro l’omologazione del cibo c’è un pericolo ben più grave, se pensiamo che la nostra costituzione fisica dipende dalla biodiversità del pianeta. Per guadagnare faticosamente un miglio verso la nostra salute, pensando anche alla fragilità biologica delle nostre generazioni e al grave momento che stiamo vivendo, non posso che pensare alla necessità di guadagnare leggi e tutele per coltivare seminare e vendere cibo sano, libero, e contrastare l’altrettanta fragilità di questo pianeta consentendo alle nuove generazioni di tornare a coltivare dignitosamente. Come una volta.
Sono apicoltore, le api sono il primo campanello d’allarme della salute della nostra terra.
Già un mese fa nel cremonese sono iniziati i trattamenti nelle campagne, iniziando anzi anticipando i danni agli insetti impollinatori. Si anticipa, perché tanto si sa che i trattamenti sono da fare. E allora meglio farli prima!
Questo comportamento criminale mi fa pensare alla schiena piegata, non la testa, di tanti contadini che si sentono ricattati dall’uso dei pesticidi per aver accettato di praticare un modello a loro dire, irreversibile.
Io spero in un uomo che pieghi la testa per il sole ma tenga la schiena dritta. Per se stesso, per il suolo, per un cibo variabile, casuale, ricco del sapore di una terra autofertile. Per tornare ad essere quel che è.